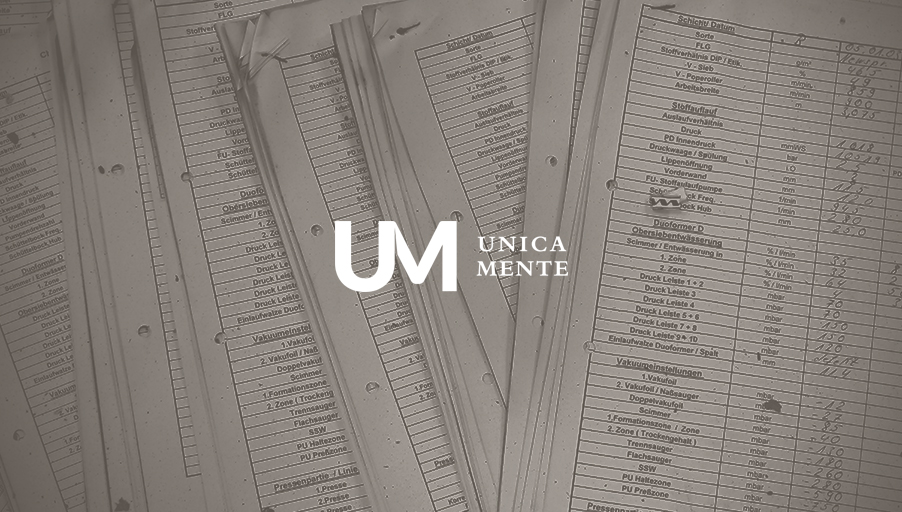1- PREMESSA
La corruzione costituisce un fenomeno variegato e complesso in grado di produrre effetti in ogni campo della vita umana.
Pubblica Amministrazione, politica, finanza, mercato: nessuno di questi settori può dirsi immune da fenomeni corruttivi.
Antichissima è la storia della corruzione; nuovissimi sono, al contrario, gli strumenti attraverso i quali viene esercitata e posta in essere.
Ed è proprio questa capacità di adattarsi ai cambiamenti sociali ed alle nuove regole che informano tanto il funzionamento della res publica, quanto la struttura dei mercati industriali e finanziari, che rende particolarmente ardua l’individuazione dei fenomeni corruttivi e, conseguentemente, la loro repressione.
È innegabile che, per un lunghissimo periodo, gli strumenti apprestati dall’ordinamento (rectius, dagli ordinamenti) nella lotta alla corruzione si siano dimostrati assolutamente inadeguati. Troppo legati, infatti, ad una visione del mondo, ormai, ampiamente superata (legislazioni ed attenzione alla corruzione diversa da Stato a Stato; scarso interesse e nessuna analisi per il fenomeno della cd. globalizzazione…) e troppo incentrati (direi quasi esclusivamente) sul rapporto tra cittadini ed amministrazione pubblica, gli strumenti di cui sopra si sono rivelati inidonei a fronteggiare un fenomeno che si muove, invece, in ambito internazionale e che si manifesta sempre più spesso anche nell’ambito dell’iniziativa economica privata e nel mercato.
Proprio con riferimento alle ipotesi di incriminazione della corruzione privata ed alle proposte di legge che, in tale direzione, sono state avanzate risulta doveroso segnalare – mi si consentirà una breve divagazione – un interessantissimo dato politico – criminale, che merita un’attenzione particolare ed è stato efficacemente evidenziato da E. Musco, in L’Illusione Penalistica, Milano 2004.
Si tratta del grande paradosso che vede, nell’arco di appena un decennio, il ribaltamento radicale della prospettiva del trattamento giuridico della cd. privatizzazione e, cioè, della scelta di togliere l’economia dalle mani pubbliche, per inserirla nel libero gioco del mercato. Del passaggio, in altri termini, da una visione della privatizzazione come antidoto certo ed efficace al fenomeno corruttivo a luogo, essa stessa, bisognoso della più efficace forma di protezione che lo Stato è in grado di apprestare.
È storia di appena dieci anni fa. Non sfuggirà nemmeno agli osservatori più distratti come la scoperta della corruzione sistemica, a seguito delle inchieste portate innanzi da tutte le Procure italiane, all’interno di quel fenomeno giudiziario noto come “tangentopoli”, abbia spinto i più autorevoli rappresentanti del mondo della politica e delle istituzioni (ma anche dell’impresa, del sindacato e, finanche, il “cittadino comune”) ad individuare le privatizzazioni come il miglior rimedio attuale contro il dilagare della corruzione: la sottrazione di sempre più ampie fette dell’economia al potere pubblico – si diceva – sarebbe stato il toccasana al male endemico della società italiana e, cioè, alla corruzione.
È ovvio che dietro un così forte input ed una così definitiva diagnosi ci fossero ragioni solide e convincenti, né avrebbe potuto di certo inficiare un siffatto esito diagnostico la presenza, peraltro sparuta, di fattispecie di corruzione privata in altri ordinamenti giuridici.
È, tuttavia, doveroso evidenziare come, a distanza di pochi anni, questo esito, questa certezza, questa “terapia”, appaia stravolta e ribaltata e, comunque privata del suo contenuto essenziale. Sulla base di una “valutazione politica” è la stessa attività imprenditoriale privata (pochi anni orsono panacea di tutti i mali), invero, ad essere indiziata di produrre corruzione a livello tale da richiedere l’immediato intervento del potere punitivo statuale.
Non è, ovviamente, un calembour, ma un concreto accadimento normativo di cui occorre cercare una spiegazione e, soprattutto, una (la) giustificazione.
A ciò si aggiunga che per troppo tempo la corruzione è stata vista come un fenomeno meramente patologico, a cui dare una risposta soltanto di tipo penal – repressivo, senza dar vita ad una seria e penetrante indagine in ordine alle sue cause e concause e, soprattutto, agli effetti, senz’altro devastanti (sul piano etico ed economico), che essa produce nei vari aspetti della vita umana. Non si è, in altri termini, svolta un’adeguata azione preventiva, in grado di eliminare quelle sacche di inefficienza ed opacità all’interno dell’amministrazione pubblica, della burocrazia, del mercato che costituiscono l’humus del quale la corruzione si nutre.
La risposta è stata affidata, nella quasi totalità dei casi, al solo diritto penale, dimenticando (o fingendo di dimenticare) che la risposta repressiva non può che costituire l’extrema ratio, in ossequio ai principi di sussidiarietà e residualità del diritto penale, costituzionalmente riconosciuti.
Ed invero, il diritto penale del futuro per avere effettiva incidenza e chance di realizzazione dovrà, necessariamente essere razionale, minimo ed effettivo.
Di contro, la continua proliferazione di leggi penali, il loro accentuato simbolismo, la produzione di esiti normativi spesso “schizofrenici”, hanno prodotto in generale una situazione di grandissima confusione che, da un lato, rischia di risolversi in una situazione di delegittimazione del sistema penale in quanto tale e che, dall’altro non ha arrecato alcun beneficio nella lotta alla corruzione. Della creazione di un sistema penale ipertrofico è certamente responsabile il legislatore che ha talvolta utilizzato, quale scorciatoia del consenso, i valori simbolici e “promozionali” impropri del diritto penale.
È, altresì, innegabile che una parte minoritaria della giurisprudenza ha fatto massiccio ricorso all’interpretazione eccessivamente estensiva delle norme penali, interpretazione impropria che – a parere di chi scrive – non dovrebbe essere utilizzata nell’ambito penale (a differenza del diritto civile, dove l’interpretazione estensiva è, al contrario, auspicabile). Il ricorso improprio all’interpretazione estensiva rappresenta una sorta di “cavallo di Troia” attraverso cui, sovente, si consente e si tollera la violazione del divieto di analogia in materia penale.
Sul punto, per quanto attiene più specificamente ai reati contro la P.A., è opportuno evidenziare, ad esempio, l’incondivisibile equiparazione tra il concetto di induzione con quello di persuasione, i cui valori semantici sono, invece, totalmenti contrastanti. Ed ancora, del pari in relazione alle forzature interpretative dei reati contro la P.A., si segnalano gli spostamenti progressivi in tema di individuazione del momento consumativo del reato di corruzione.
In ordine a tale individuazione, secondo un orientamento giurisprudenziale, ormai risalente nel tempo, infatti, in caso di promessa la consumazione del reato si verificherebbe non già con l’accettazione della stessa, bensì con il successivo versamento del denaro (e, nel caso di versamento in più tranche, all’ultima delle stesse).
In altri termini, si è sostenuto che, in caso di promessa accettata dal pubblico ufficiale, la ricezione di quanto pattuito, successiva alla promessa, segnerebbe la consumazione del reato. Viceversa, qualora la promessa non sia adempiuta e manchi, quindi, la dazione, il momento consumativo resterebbe ancorato a quello dell’accettazione della promessa.
Alcune pronunce della S.C., tra l’altro (per fortuna) rarissime, si sono, poi, spinte oltre arrivando ad affermare che la promessa e la successiva dazione darebbero vita a condotte “reciprocamente autonome”, di tal che, in presenza di entrambe, si realizzerebbero due distinti reati uniti dal vincolo della continuazione ai sensi dell’art 81 c.p. (cfr. ex pluribus Cass. pen., sez. VI, 12.11.1996).
Entrambi gli orientamenti non possono essere in alcun modo condivisi.
Ed invero, è appena il caso di sottolineare come il disvalore della corruzione vada in ogni caso individuato nel pactum sceleris e, cioè, nello scambio dei consensi dei due protagonisti legato al compenso (o alla promessa di compenso ) indebito.
Si tratta, del resto, di una circostanza comprovata dal fatto che nella corruzione antecedente, qualunque sia la condotta, l’atto oggetto dell’accordo – restando fuori dagli elementi costitutivi del reato – non è necessario ai fini della consumazione del reato né, tantomeno, ai fini dell’individuazione del luogo di commissione del reato.
Ebbene, se non è necessario né rileva per la consumazione neppure il compimento dell’atto oggetto dell’accordo, non si comprende perché, a maggior ragione, una simile rilevanza dovrebbe essere attribuita al successivo mero adempimento della promessa e, cioè, alla materiale consegna di quanto pattuito. Mantenimento della promessa che, come innanzi evidenziato, non costituisce una condizione necessaria ai fini della configurabilità del reato di corruzione e che, pertanto, deve essere considerato alla stregua di un post factum non punibile, potendo tutt’al più produrre effetti ai fini della determinazione della pena.
Una simile interpretazione trova, del resto, conferma nel testo degli articoli di riferimento in cui le due condotte della dazione e della promessa, presentandosi assolutamente equivalenti e fungibili tra di loro, sono poste in evidente rapporto di alternatività, di tal che risulterebbe privo di senso attribuire alle medesime un ruolo così diverso ai fini della consumazione.
Per quanto attiene, poi, l’orientamento giurisprudenziale in forza del quale dazione e promessa darebbero vita a condotte “reciprocamente autonome” e, quindi, a distinti reati uniti dal vincolo della continuazione, è appena il caso di sottolineare come, incriminando separatamente e cumulativamente promessa e dazione, si corra il rischio di violare sia il principio di legalità sia il divieto di bis in idem, atteso che la dazione presuppone indefettibilmente un previo accordo, assorbendone il disvalore penale. Punendo alternativamente l’una e l’altra condotta, pertanto, si incorrerebbe in una parziale duplicazione delle pene, non sufficientemente temperata dalla diminuente prevista per il reato continuato.
La realtà è che alcuni orientamenti appaiono dominati dallo sforzo interpretativo estensivo finalizzato a postergare il momento consumativo, per differire l’estinzione del reato per prescrizione; scopo certamente comprensibile a fronte dell’insidiosità e della dannosità sociale dei fenomeni corruttivi, ma da perseguire con un’apposita previsione legislativa e non già con forzature interpretative irrispettose dei principi generali dell’ordinamento (in primis il principio di legalità).
Ritornando a quello che costituisce più propriamente il tema dell’odierno incontro va evidenziato che, a partire dalla fine degli anni ‘80 e soprattutto negli anni novanta, dietro l’impulso di organismi ed istituzioni internazionali e comunitarie (ONU, OCSE, Consiglio dell’Unione Europea) si è, però, cominciato a modificare l’approccio ai fenomeni lato sensu corruttivi, cercando di trovare (ed in molti casi trovando) strumenti idonei a fronteggiare un fenomeno in continua espansione – che, in non pochi casi, ha assunto un vero e proprio carattere “sistemico” – e sempre più insidioso.
Tre sono, in particolare, gli aspetti su cui i vari incontri e le varie convenzioni internazionali che si sono succedute (Parigi 1997, Londra 1999, Palermo 2000, Merida 2003) hanno posto maggiormente l’attenzione:
- la necessità di dar vita ad un’armonizzazione delle normative nazionali in tema di corruzione, in considerazione del carattere sempre più internazionale o transnazionale dei fenomeni corruttivi;
- l’introduzione della responsabilità per corruzione nel settore privato;
- la responsabilità anche delle persone giuridiche (in primis, le società commerciali), atteso che gli episodi di corruzione non sono più soltanto sintomo di devianze individuali, ma costituiscono, non di rado, vere e proprie “politiche d’impresa”.
In tale sede, considerata la vastità e la complessità dell’argomento, non è possibile dare vita ad un approccio sistematico al fenomeno corruttivo. Pertanto, tenendo ben presenti le linee guida emerse dalle convenzioni internazionali di cui sopra, si porrà l’accento su alcuni aspetti particolari che caratterizzano i reati di corruzione e sulle risposte apprestate dall’ordinamento.
Segnatamente ci si occuperà:
- dei limiti di una risposta esclusivamente penale al fenomeno della corruzione e della necessità di porre in essere anche strumenti di tipo preventivo, con un accenno all’istituzione dell’Alto Commissario per la corruzione ed ai protocolli di intesa da esso siglati;
- dell’introduzione (vera o presunta; condivisibile o non condivisibile) della responsabilità penale per corruzione nel settore privato;
- della responsabilità, ai sensi del decreto legislativo 231/2001, delle persone giuridiche per i reati commessi nel suo interesse.
2 – LIMITI DELL’INTERVENTO PENALE: ALTO COMMISSARIO E PROTOCOLLI D’INTESA
La corruzione costituisce, come è noto, un fenomeno criminale altamente complesso ed ambiguo.
Innumerevoli – oltre che eterogenee – sono, infatti, le sue cause; numerose sono, del pari, le sue conseguenze.
Negli ultimi anni (rectius negli ultimi decenni) la situazione si è notevolmente complicata, atteso che il fenomeno corruttivo, strutturalmente di natura occulta, ha in molti casi acquisito un carattere sistemico, venendo ad interagire “stabilmente con le regole di funzionamento di apparati burocratici e di strutture sociali, divenendone, per così dire, parte costitutiva ed integrante” (A. Spena, Il Turpe Mercato. Teoria e riforma dei delitti di corruzione pubblica, Milano, 2003).
Di fronte ad una realtà così complessa ed articolata, il diritto penale costituisce uno strumento di per sé insufficiente a fronteggiare il fenomeno.
Autorevoli commentatori hanno, al proposito, lucidamente affermato che, in materia di lotta alla corruzione, «il diritto penale ha già dato, forse (e senza forse), sin troppo; a questo punto bisogna bussare ad altre porte» (si veda, per tutti, Padovani).
Ed invero, perché la lotta alla corruzione sia efficace, arrivando ad ottenere risultati di lungo periodo e fuggendo da logiche “emergenziali”, è necessario agire, innanzitutto, sulle cause più profonde e persistenti del fenomeno: dovrebbe quindi incentrarsi sui piani della trasparenza dell’azione amministrativa, della sua efficienza, della fiducia dei cittadini in essa.
Nell’ambito di una strategia di prevenzione a trecentosessanta gradi è, pertanto, opportuno (necessario) predisporre strumenti in grado di consentire alla stessa P.A. di produrre i necessari anticorpi contro le minacce corruttive. Da un lato, incrementando la trasparenza dell’attività amministrativa; dall’altro, provvedendo a creare un sistema di strumenti e misure che consentano alla stessa P.A. di monitorare costantemente ed efficacemente il proprio “stato di salute”, così che si possa dall’interno, e con maggiore immediatezza ed incisività, intervenire su situazioni anomale, che lascino paventare eventuali sviluppi corruttivi.
Proprio per soddisfare tali esigenze è stato istituito, con il d.P.R. 6 ottobre 2004, n. 258, l’«Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito nella pubblica amministrazione».
Scopo precipuo dell’Alto Commissario è quello di potenziare il sistema italiano di lotta alla corruzione tanto sul piano della prevenzione, quanto sul piano di un sollecito impulso alla repressione dei fatti di corruzione.
Segnatamente, l’Alto Commissario ha il potere di disporre indagini, anche di natura conoscitiva, di iniziativa propria o per fatti denunciati (con esclusione di quelli indicati in denuncie anonime), o su richiesta delle amministrazioni, allo scopo, tra l’altro, di accertare l’esistenza di fenomeni di corruzione e di illecito all’interno della pubblica amministrazione.
L’Alto Commissario ha, altresì, l’obbligo di denunciare, all’autorità giudiziaria i fatti di reato ed alla Corte dei conti, nei casi previsti dalla legge, i fatti nei quali sia ravvisabile danno erariale, dei quali sia venuto a conoscenza nell’esercizio delle funzioni; nonché, alle rispettive amministrazioni eventuali fatti, emersi dagli accertamenti compiuti, da cui possa evincersi la responsabilità amministrativa e disciplinare di un qualche pubblico dipendente. La forte aspirazione verso un potenziamento della prevenzione dei fenomeni lato sensu corruttivi, si coglie, poi, con manifesta evidenza dal complesso degli altri poteri attribuiti all’A.C. Essa dovrebbe avere secondo la disposizione istitutiva, in particolare, il potere di disporre indagini, anche di natura conoscitiva, di iniziativa propria o per fatti denunciati (con esclusione di quelli indicati in denuncie anonime), o su richiesta delle amministrazioni, allo scopo, questa volta, di accertare le cause e le concause di fenomeni di corruzione o di illecito o di pericoli di condizionamento da parte di organizzazioni criminali all’interno della pubblica amministrazione; il potere di disporre la elaborazione di analisi e studi sull’adeguatezza e congruità del quadro normativo, nonché delle eventuali misure poste in essere dalle amministrazioni per prevenire e per fronteggiare l’evolversi del fenomeno corruttivo; il potere, infine, di disporre attività di monitoraggio su procedure contrattuali e di spesa e su comportamenti, e conseguenti atti, da cui possa derivare danno erariale.
Ebbene, pur non essendovi dubbi sui notevoli benefici prodotti dall’istituzione di detto organismo, non è possibile, in tale sede, non evidenziarne i limiti e le contraddizioni che, purtroppo, lo caratterizzano.
Ed invero, va certamente accolta con favore l’istituzione di un organismo che ha per scopo, tra l’altro, quello di costituire un punto di raccolta – interno alla Pubblica amministrazione – di informazioni e cognizioni relative alle condizioni di salute della stessa pubblica amministrazione e, per così dire, al suo grado di propensione alla corruzione. Un organismo, in altri termini, deputato a costituire una sorta di banca dati permanente in cui convogliare un insieme quanto più corposo ed approfondito possibile di cognizioni su profili (cause e concause di fenomeni corruttivi, adeguatezza del quadro normativo, efficienza e correttezza delle procedure contrattuali e di spesa) che è fondamentale tenere sotto controllo, ove si voglia veramente pensare di poter porre rimedio alle più gravi forme di gestione illecita della cosa pubblica. La conoscenza e la “sistemazione” delle conoscenze costituisce, infatti, il primo fondamentale passo di ogni strategia di lotta alla corruzione: se è vero che questa costituisce un fenomeno che vive nell’opacità, e dell’opacità e della scarsa trasparenza nel funzionamento dell’amministrazione pubblica, della segretezza o della scarsa visibilità di certi tipi di interrelazioni pubblico/privato.
Sin qui gli innegabili benefici prodotti dall’istituzione dell’organismo suddetto.
Va, tuttavia, evidenziato come le prospettive aperte dall’emanazione del decreto in oggetto si prestino anche ad alcune considerazioni meno entusiastiche. Appare, soprattutto, non condivisibile la scelta di attribuire all’Alto Commissario, tra gli altri, anche il compito di svolgere indagini tese ad accertare l’esistenza di fenomeni di corruzione e di illecito all’interno della Pubblica amministrazione. Ciò, da un lato, non fa altro che sovrapporre un’ulteriore competenza (senza adeguate garanzie per il sospettato) a competenze già radicate ed esistenti (quali, in primo luogo, quelle delle diverse procure della Repubblica), con conseguenti gravissimi pericoli di arbitrii, confusioni e conflitti; e, dall’altro, rischia di paralizzare l’attività dello stesso Alto Commissario, il quale potenzialmente potrebbe divenire il destinatario di una mole insostenibile di denunce e richieste d’indagine, virtualmente pari alla somma delle segnalazioni che, per fatti lato sensu corruttivi, arrivano alle diverse procure d’Italia.
Va, altresì, evidenziato come non del tutto peregrino sia il pericolo paventato da alcuni commentatori (tra gli altri, Oberdan Forlenza), secondo i quali aver affiancato all’Alto Commissario ben due vice – commissari e cinque esperti, senza che a tale aumento di personale corrisponda un aumento ed una migliore redistribuzione dei compiti, rischia di “appesantire” ed in parte deresponsabilizzare tale organismo.
Particolare rilievo assumono, in ogni caso, i protocolli d’intesa e le convenzioni intercorse tra l’Alto Commissario ed alcuni organi istituzionali.
Tali protocolli prendono le mossa da un dato innegabile e di fondamentale importanza: la corruzione non è soltanto un fenomeno criminale (con i conseguenti risvolti penalistici che ne derivano) ma costituisce anche – e forse soprattutto – un freno alle attività economiche, alla correttezza ed alla libertà del mercato, in altre parole allo sviluppo.
Tali protocolli d’intesa hanno, pertanto, lo scopo di creare una sinergia, una collaborazione, tesa ad individuare e conseguentemente reprimere i fenomeni corruttivi, tra l’Alto Commissario ed alcuni organi istituzionali, all’interno dei quali possono annidarsi episodi di corruzione o che per l’attività svolta possono venire a conoscenza di situazioni “sospette” e potenzialmente riferibili a fenomeni corruttivi.
Tra i protocolli d’intesa siglati dall’Alto Commissario si ricordano:
- Protocollo d’intesa con il Comune di Napoli (22.02.2008);
- Protocollo d’intesa con l’Agenzia delle Entrate (21.12.2007)
- Protocollo d’intesa con la Corte dei Conti (23.10.2007)
- Protocollo d’intesa con il Ministero delle Infrastrutture (19.10.2007)
- Protocollo d’intesa con il Ministero per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione (10.10.2007)
- Protocollo d’intesa con la commissione parlamentare antimafia (27.06.2007)
- Protocollo d’intesa con la Guardia di Finanza (14.10.2005)
3- VERSO LA PUNIBILITA’ DELLA CORRUZIONE NEL SETTORE PRIVATO?
Negli ultimi anni, anche per l’impulso di organismi internazionali (ONU ed OCSE) e comunitari, si è aperto nel nostro paese un acceso dibattito circa l’opportunità di istituire una nuova ipotesi, penalmente sanzionata, di corruzione nel settore privato.
Proprio al fine di recepire l’art. K.3 del Trattato sull’Unione Europea, sulla corruzione nel settore privato, è stata avanzata nel 2002, per iniziativa del deputato Kessler, una proposta di legge (n. 3215/2002) tesa ad introdurre nel codice penale un nuovo articolo – l’art. 513-ter – del seguente tenore: “Corruzione nel settore privato. Chiunque, dirigendo un ente di diritto privato, lavorando alle dipendenze dello stesso o comunque prestando la sua opera a favore dello stesso, riceve per sé o per un terzo denaro od altra utilità o ne accetta la promessa, allo scopo di compiere od omettere un atto in violazione di un dovere nell’ambito di un’attività d’affari è punito con la reclusione da uno a quattro anni”.
Per violazione di un dovere ai sensi del primo comma deve intendersi qualsiasi comportamento sleale che costituisca una violazione di un obbligo legale, di normative professionali o di istruzioni professionali ricevute o applicabili nell’ambito dell’attività dell’ente.
Alla stessa pena soggiace chi dà o promette danaro od altra utilità nei casi indicati dal primo comma.
Nei casi di speciale tenuità si applica la pena della multa da duemila a cinquemila euro.
Il fatto è punibile ove la condotta produca o possa produrre una distorsione della concorrenza nell’ambito del mercato ovvero danni economici all’ente o a terzi anche attraverso una non corretta aggiudicazione o una non corretta esecuzione di un contratto.
Dal tenore della condizione di punibilità, oltre che dall’inserimento nel capo dei delitti contro l’industria e il commercio e dalla collocazione sistematica dopo l’art. 513-bis del codice penale, risulta evidente il rapportarsi del nuovo reato proposto anche, rectius soprattutto, al modello di tutela della concorrenza.
Ed infatti il vigente art. 513-bis del codice penale limita la tutela della concorrenza, sanzionando soltanto le intimidazioni tipicamente mafiose atte ad incidere su quella fondamentale legge di mercato che vuole la concorrenza non solo libera, ma anche lecitamente attuata (Cassazione, Sez. III, sent. n. 46756/2005).
Tale proposta, tuttavia, non è mai divenuta legge.
Successivamente, con la Decisione quadro 22 luglio 2003, n. 2003/568/GAI si è convenuto che gli Stati membri della UE “devono trovare il modo di ratificare al più presto” la Criminal law convention on corruption del Consiglio d’Europa, adottata il 3-4 novembre 1998 ed aperta alla firma il 27 gennaio 1999 (firmata, tra l’altro dall’Italia) in quanto la corruzione nel settore privato “costituisce una minaccia allo Stato di diritto e inoltre genera distorsioni di concorrenza riguardo all’acquisizione di beni o servizi commerciali e ostacola un corretto sviluppo economico …”.
Il vero obiettivo della Decisione quadro è, tuttavia, quello di garantire che sia la corruzione attiva sia quella passiva nel settore privato siano considerate illeciti penali in tutti gli Stati membri, che anche le persone giuridiche possano essere considerate colpevoli di tali reati e che le sanzioni siano effettive, proporzionate e dissuasive.
Anche tale Decisione non ha, però, trovato concreta applicazione nel nostro ordinamento, ritenendosi sufficiente, ai fini del rispetto delle indicazioni della Comunità Europea, il vigente regime di responsabilità parapenale delle società e di punizione dell’infedeltà patrimoniale in ambito societario.
Alla stregua di quanto sin qui affermato, la domanda iniziale con cui si è aperto tale intervento, dovrebbe ricevere risposta negativa.
Occorre, tuttavia, evidenziare come in almeno in un caso – sebbene, a parere di chi scrive, assolutamente sui generis – si sia prevista un’ipotesi di responsabilità penale per fenomeni corruttivi commessi nel settore privato.
Ed invero, con l’art. 35 della L. 28 dicembre 2005, n. 262 sulla tutela del risparmio e del mercato finanziario (cd. “legge sul risparmio”), sono state introdotte nel D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 diverse ipotesi delittuose di corruzione dei responsabili della revisione su società quotate o da queste controllate o che emettono strumenti finanziari di rilevante diffusione (artt. 174-bis e 174-ter) che possono essere lette in chiave sia di rafforzamento dello stampo pubblicistico delle società di revisione, sia di sanzione della corruzione nel settore privato.
Incriminazione, quest’ultima, da tenere assolutamente distinta, da quella prevista dall’art. 2635 del codice civile (“Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità”) .
Ed invero, mentre il reato ex art. 2635 del codice civile, pure esso commettibile dai responsabili della revisione, è un reato di evento in quanto si perfeziona con il prodursi di un nocumento per la società, il reato di cui all’art. 174-ter, commettibile esclusivamente dai responsabili della revisione, ha natura di reato di pericolo e presenta, pertanto, profili analoghi alle ipotesi di corruzione previste dal codice penale. Diversi sono, in altri termini, i beni giuridici tutelati: la previsione incriminatrice di cui all’art. 2635 c.c. tutela, infatti, il patrimonio sociale; l’oggetto giuridico della previsione di cui agli artt. 174-bis e 174-ter è, invece, costituito dalla tutela del mercato finanziario e, conseguentemente, delle regole di concorrenza leale che lo sorreggono.
Va, altresì, evidenziato che mentre il reato di cui all’art. 2635 c.c. è perseguibile a querela di parte (essendo posto a tutela di interessi interni alla società, della cui lesione essa può o meno dolersene), il regime sanzionatorio della corruzione dei revisori introdotto dalla legge n. 262/2005, sganciato definitivamente dall’esistenza o dal pericolo di un danno patrimoniale interno alla società, prevede la procedibilità di ufficio.
Ne consegue che detta corruzione, punita con la reclusione da uno a cinque anni, aumentabile fino alla metà in caso di concorso dei revisori con gli apici della società revisionata, partecipa a livello comparatistico della struttura propria del cosiddetto modello pubblicistico, che raccorda la corruzione privata alla corruzione amministrativa recependone lo schema, e del cosiddetto modello di tutela della concorrenza, dal momento che la corruzione del revisore è punita perché lesiva della regolarità del mercato finanziario e quindi anche delle regole di concorrenza leale che lo sorreggono.
A questo punto, evidenziato come l’unica ipotesi di incriminazione per fenomeni di corruzione nel settore privato, allo stato esistente, sia rappresentata dalla responsabilità dei revisori (i quali, come anticipato, pur essendo soggetti di diritto privato svolgono una funzione pubblicistica o para-pubblicistica), occorre tornare al quesito iniziale e chiedersi se sia opportuno introdurre ulteriori ipotesi di responsabilità per corruzione nel settore privato.
La risposta deve essere, almeno in parte, negativa, qualora si voglia introdurre un’ipotesi generalizzata di corruzione privata, modellata ed ancorata alla normativa prevista in tema di corruzione nel settore pubblico. Viceversa, andrebbe introdotta una normativa volta a tutelare in modo più incisivo il mercato e la libera concorrenza, anche (ma non solo) attraverso l’incriminazione di specifiche ipotesi di corruzione nel settore privato.
Segnatamente, si auspica l’introduzione di una normativa complessa dove, accanto alla previsione di fattispecie incriminatrici volte a tutelare la collettività dai fenomeni di corruzione nel settore privato dotati di reale carica lesiva (rectius, offensività), si prevedano ulteriori tipologie di sanzioni (quali, ad esempio sanzioni pecuniarie) per punire (o scoraggiare) ipotesi minimali di mercimonio nel settore privato.
La Decisione quadro 22 luglio 2003 della UE ed il dibattito interno che ne è seguito sembrano, invece, orientate ad “una ricostruzione eticizzante del mercato”, che si muove sul terreno scivoloso “della moralizzazione dell’attività imprenditoriale privata”, laddove invece, paradossalmente, le “tangenti private non possono assumere altro rilievo che quello di un costo” per le società e le imprese che operano nel diritto privato.
Simili affermazioni – mutuate dalla teoria funzionalistica dei fenomeni corruttivi, di matrice anglosassone (per una critica all’approccio funzionalista si veda Becquart-Leclercq, Paradoxes of Political Corruption: A French View) – senz’altro “forti” , vanno, tuttavia, sebbene temperate, tenute ben in considerazione allorchè si intenda dar vita ad una fattispecie generale di incriminazione della corruzione privata che sia effettivamente rispettosa dei principi di tassatività e determinatezza e che, nel contempo, tuteli adeguatamente la concorrenza di mercato.
Occorre, a tal fine, chiedersi innanzitutto quale sia il significato di “violazione di un dovere”, perifrasi che riecheggia in quasi tutte le proposte di legge avanzate al fine di introdurre l’incriminazione per corruzione privata nel nostro ordinamento.
Ebbene per violazione di un dovere non può che intendersi l’inadempimento di una regola di correttezza commerciale. Se così è, occorre ulteriormente chiedersi quale sia il ramo dell’ordinamento giuridico più idoneo a garantirne l’integrità. Difficile (se non impossibile) negare, allora, che il livello di lesività sia, nella gran parte dei casi, talmente basso da far apparire la reazione penale assolutamente sproporzionata e, quindi, ingiustificata.
Per fronteggiare un siffatto inadempimento potrebbero essere addirittura sufficienti i codici di comportamento, opportunamente rivalutati nell’attuale momento storico o, al più, gli ordinari strumenti della tutela civil – lavoristica, rispettando in tal modo il principio di sussidiarietà e residualità del diritto penale.
Per concludere, ai fini di apprestare una più incisiva tutela al mercato ed alla concorrenza (questo dovrebbe essere, infatti, il fine ultimo di un’eventuale incriminazione per corruzione nel settore privato), pare preferibile, piuttosto che introdurre una fattispecie generale di incriminazione della corruzione privata, troppo legata ad aspetti e schemi pubblicistici, prevedere strumenti ad hoc (anche, ma non solo, di tipo penalistico) in grado di assicurare, nel rispetto delle garanzie dell’individuo, l’osservanza delle regole della concorrenza e la tutela della libertà e della correttezza del mercato.
Occorre, in altri termini, partire da un dato semplice ma di fondamentale importanza: la fattispecie delittuosa della corruzione nel settore pubblico è posta a tutela della trasparenza e dell’imparzialità (il cd. “buon andamento”) della Pubblica Amministrazione; l’eventuale ipotesi di corruzione nel settore privato mira, invece, a tutelare e proteggere il libero giuoco della concorrenza. Se diversi sono i beni giuridici meritevoli di tutela, diversa dovrà essere, necessariamente, la risposta dell’ordinamento.
In particolare, per quanto attiene la corruzione nel settore privato, la risposta repressiva del diritto penale dovrà intervenire non già in presenza di qualsiasi episodio astrattamente riconducibile allo schema della corruzione (cosa che avviene, invece, nel settore pubblico, dove ai fenomeni corruttivi non può che attribuirsi anche un disvalore, per così dire, etico), ma soltanto in presenza di fenomeni effettivamente idonei a restringere o inquinare in modo sensibile la libera concorrenza.
4- CORRUZIONE: RESPONSABILITA’ DEGLI ENTI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001
Se si sofferma l’attenzione sui principi che informano il diritto penale, si deve constatare che l’impresa non è, in quanto tale, destinataria di specifica sanzione. Destinataria delle sanzioni penali è, infatti, soltanto la persona fisica che pone materialmente in essere l’attività.
Nel caso in cui l’impresa sia individuale, tuttavia, la normale identificazione tra essa ed il suo titolare fa sì che la sanzione a carico di quest’ultimo finisca per colpire anche l’impresa.
La questione si pone in termini del tutto differenti quando l’impresa fa capo ad enti collettivi (ad es. società), tanto più se muniti di personalità giuridica.
In questo caso, infatti, va sottolineato che un sistema penale incentrato sulla punizione di figure illimitatamente sostituibili (fungibili), quali amministratori, sindaci etc…, ha il difetto di non incidere sull’effettiva capacità dell’impresa di perpetrare modelli illeciti. L’importanza della questione è evidente dato che l’impresa, specie se non di piccole dimensioni, si presenta prevalentemente nelle forme delle società (soprattutto s.p.a.).
Di qui la particolare rilevanza che ha, nell’ambito del diritto penale societario, il problema se la persona giuridica possa essere o meno soggetto attivo di reato.
È controverso se alla stregua dell’art. 27 Cost. debbano o meno ravvisarsi preclusioni all’affermazione della responsabilità penale delle persone giuridiche. Non vi sono, in ogni caso, dubbi che il diritto positivo italiano non preveda la responsabilità penale delle persone giuridiche, potendo essere soggetto attivo del reato soltanto la persona fisica, secondo l’antico brocardo “societas delinquere non potest”.
L’inadeguatezza del principio di irresponsabilità delle persone giuridiche si è manifestata con sempre maggiore intensità man mano che è progredita l’internazionalizzazione dei mercati. La materia ha assunto risalto soprattutto con riguardo al tema della corruzione, utilizzato come strumento di conquista di nuovi mercati.
Di qui una forte tensione internazionale che ha portato all’adozione di alcune convenzioni (Convenzione OCSE di Parigi del 17 novembre 1997; Convenzione Europea del 1997, Carta di Merida del 2003).
L’esecuzione delle convenzioni citate è avvenuta in Italia in una duplice direzione.
In primo luogo, la legge 300/2000 ha introdotto nel codice penale l’art. 322 bis, concernente l’estensione dei delitti di peculato, concussione e corruzione degli esponenti della Comunità Europea e degli stati esteri.
In secondo luogo, con la medesima legge 300/2000 è stata data delega al governo per l’introduzione della responsabilità degli enti. In esecuzione di tale delega, è stato emanato il d.lgs. 231/2001.
A fronte del tenore dell’art. 27 Cost., il legislatore ha ritenuto di non poter introdurre una responsabilità penale delle persone giuridiche ed ha, perciò, ripiegato su di una responsabilità amministrativa, ma in realtà modellata sui principi che caratterizzano la responsabilità penale.
Ecco, quindi, che a prescindere dalla terminologia utilizzata, è stata introdotta nell’ordinamento italiano una diretta responsabilità da reato degli enti. Tale responsabilità, proprio per le peculiarità che la caratterizzano, è stata qualificata come tertium genus e da alcuni, addirittura, come un’ipotesi di responsabilità “parapenale”.
Il Decreto Legislativo 231/2001, e le successive modifiche ed integrazioni, hanno introdotto un principio fino a quel momento totalmente estraneo alla cultura giuridica italiana, quello della responsabilità amministrativa (rectius, “quasi – penale”) degli enti collettivi (comprese quindi le imprese), derivante da reati commessi a vantaggio o nell’interesse dell’ente stesso da parte di persone che:
- a) rivestano funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione degli enti medesimi;
- b) esercitino, anche di fatto, la gestione o il controllo dell’ente;
- c) siano sottoposte alla direzione dei precedenti.
I principali reati indicati dalla normativa di riferimento, che determinano la responsabilità amministrativa/penale di cui sopra, sono quelli relativi ai rapporti con la Pubblica Amministrazione ed i c.d. reati societari.
Per ciò che attiene più propriamente alla corruzione, l’articolo 25 dispone che:
“Concussione e corruzione
- In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.
- In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
- In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell’articolo 319-bis quando dal fatto l’ente
ha conseguito un profitto di rilevante entita’, 319-ter, comma 2, e 321 del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
- Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all’ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.
- Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.”
Tra le sanzioni previste, oltre a quelle pecuniarie (comprese tra i 50 milioni e i 3 miliardi di vecchie lire) la normativa contempla sanzioni di natura interdittiva ( interdizione all’attività; sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze e concessioni; esclusione da agevolazioni, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi, ecc.) che possono compromettere gravemente la normale prosecuzione dell’attività aziendale. Ma il rischio più concreto, anche in considerazione della vasta e “severa” giurisprudenza in materia, è dato dall’adozione, su richiesta del PM, dei provvedimenti interdittivi di natura cautelare.
Va, altresì, segnalato che le sanzioni interdittive possono essere applicate anche in via definitiva, qualora ne ricorrano i presupposti.
La confisca è sempre disposta, ha ad oggetto il profitto del reato e può essere eseguita per equivalente. La confisca del beneficio che l’ente ha tratto dal reato deve intervenire anche se l’ente non sia stato reputato responsabile dell’illecito.
Va evidenziato, sul punto, che la responsabilità dell’ente è, in ogni caso, autonoma. Ciò significa che essa sussiste anche quando l’autore del reato non sia stato individuato o non sia imputabile e quando il reato si sia estinto per causa diversa dall’amnistia.
I criteri di imputazione variano a seconda della posizione dell’autore del reato.
Quando questi si trova in una posizione apicale vale il principio di identificazione: la fattispecie è, cioè, trattata come se il reato fosse stato posto in essere direttamente dall’ente.
Quando, viceversa, il reato è stato commesso da un soggetto in posizione subordinata, è necessario, ai fini della sussistenza della responsabilità in capo all’ente, che la commissione del reato sia stata resa possibile dall’inosservanza, da parte di chi è in posizione apicale, degli obblighi di vigilanza e direzione.
A ben vedere, nonostante le differenze evidenziate, il fondamento della responsabilità dell’ente è il medesimo in entrambi i casi. Esso va ravvisato nella mancanza di una organizzazione dell’impresa idonea a prevenire la commissione di reati. L’ente, in altri termini, è responsabile per i reati commessi, in quanto non ha avuto l’accortezza di creare una struttura organizzativa idonea ad evitare che, nel suo ambito, siano commessi determinati reati (cd. “colpa in organizzazione”).
La possibilità di evitare o ridurre l’applicazione delle sanzioni è subordinata all’adozione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire il compimento dei reati ex D.Lgs. 231/2001.
Statuisce , infatti, l’articolo 6:
“Se il reato e’ stato commesso dalle persone indicate nell’articolo 5, comma 1, lettera a), l’ente non risponde se prova che:
- a) l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli e’ stato affidato ad un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) non vi e’ stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo preposto.
In relazione all’estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di organizzazione devono rispondere alle seguenti esigenze:
- a) individuare le attivita’ nel cui ambito possono essere commessi reati;
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalita’ di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli;
- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.
I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati.
Negli enti di piccole dimensioni i compiti di vigilanza e controllo possono essere svolti direttamente dall’organo dirigente.
I modelli di cui alla legge 231/2001 devono, quindi, essere basati su un’effettiva ripartizione delle funzioni dell’ente e devono prevedere l’adozione di un codice etico, di specifiche procedure per le fasi decisionali e del controllo conseguente, e soprattutto un incisivo sistema disciplinare atto a scoraggiare il compimento dei reati. Devono essere, altresì, modelli non standardizzati, ma basati sulla realtà di ogni singola azienda. E’, inoltre, prevista la nomina di un Organismo di Vigilanza, dotato di imparzialità e competenze idonee, con il compito di verificare l’effettività del modello, il suo funzionamento e le necessità di aggiornarlo.
Dopo essere stato accompagnato per lungo tempo da una sorta di “non applicazione”, in attesa della stesura da parte delle associazioni di categoria delle linee guida previste dal Decreto, di recente i Giudici per le indagini preliminari hanno cominciato ad applicare sempre più frequentemente le sanzioni ex D. Lgs. 231/2001. I rischi connessi a tale normativa risultano quindi sufficienti a far comprendere l’importanza per ogni impresa di dotarsi dei modelli organizzativi previsti.